
Carissimi!
Ultimo appuntamento di questa settimana all’insegna del “Best of” e non potevamo certo non rimembrar lo passo e parlare di quelle serie TV che hanno definitivamente chiuso i battenti nel 2016 e di cui sentiremo di più la mancanza, vuoi perché cancellate (magari anche senza preavviso – con annesse maledizioni verso produttori e autori), vuoi perché giunte fisiologicamente al capolinea.
Penny Dreadful

Eccomi alle prese con la fine di Penny Dreadful: sono proprio io, lo confesso.

Penny Dreadful è stato molte cose per me: tensione, psicologia, POESIA, passione, ansia. Mi è entrato sotto pelle, così come i suoi protagonisti. Aspettare il rinnovo di una serie TV mette sempre ansia, un’ansia terribile in effetti, ma scoprire a un passo dal season finale che proprio quel finale non sarà solo un season finale ma un SERIES FINALE, ebbene, questo è PSICOLOGICAMENTE DEVASTANTE. Ecco, i produttori di Penny ci hanno trattati così, dicendo che la storia di Vanessa era da sempre stata progettata per seguire un ciclo narrativo di tre stagioni. MALEDETTI, IO MR CHANDLER L’AVREI DI CERTO SEGUITO ALMENO PER ALTRE – che ne so – DUE STAGIONI!!!
(Ma torniamo serie per un istante) In questi tre anni ho imparato ad amare alla follia LA CREATURA, per la sua profonda umanità, per la sua enorme cultura letteraria – nonostante il basso ceto sociale (sicuramente non paragonabile a quello di Vanessa o Sir Malcom), per il suo animo gentile, e ovviamente per il suo eterno #maiunagioia. Ho imparato a odiare Brona/Lily, come si può odiare solo il lunedì mattina perché costretti ad andare al lavoro, per la sua tracotanza, la sua ingratitudine e per le sue manie di grandezza. Ho imparato a provare pena per il Dr Frankenstein e la sua fragilità, la sua necessità di essere amato, per poi rimanere affascinata dalla forza interiore che è riuscito a trovare. Personaggi complessi che in questo percorso ci hanno mostrato tutte le infinite sfaccettature del loro carattere, che ci hanno presi per mano e portati su quella strada insieme a loro.
In Penny Dreadful non c’è mai stato molto spazio per l’amore, una storia d’amore di quelle classiche per intenderci, eppure nella seconda stagione ho adorato l’avvicinamento tra Vanessa e Mr Chandler, un avvicinamento che, ahimè, ci ha poi portati all’epilogo finale. Un finale che, a mio avviso non è stata altro che la liberazione della protagonista, liberazione che è avvenuta per mano di colui il quale era stato pensato proprio per proteggerla e supportarla. (E comunque io da shipper accanita anche di un palo con il pavimento, loro due li ho shippati all’inverosimile, all’inverosimile. Sono davvero una sfigata di prima categoria…).

Devo ammettere che la terza stagione ha avuto degli alti e bassi molto marcati, alcune storyline sono partite per la tangente per non fare mai più ritorno, mi riferisco per esempio alla storia di Dorian e Lily/Brona: una storia ben strutturata, ma che all’interno del contesto in cui i vari protagonisti ruotavano c’entrava come i cavoli a merenda, niente. Stessa cosa si può dire per l’inserimento di personaggi con un potenziale non enorme, di più ancora, come il Dr Jekyll, che alla fine sono stati abbandonati come si fa con l’immondizia il giorno in cui passa la nettezza urbana. Questa cosa per me ha dell’assurdo. In generale, devo dire che proprio la terza stagione è stata per me la “peggiore”, se peggiore si può definire intendiamoci, ma è stata sicuramente la stagione costruita più velocemente, senza uno schema narrativo chiaro e strutturato su tutti i fronti, almeno per metà stagione. Poi sicuramente la corsa verso il finale ha segnato una ripresa, e la scena finale (che scena finale!) mi ha “pienamente” soddisfatta, ma solo perché assolutamente in linea con il percorso del personaggio (di Vanessa).
Penny Dreadful ci ha regalato una fotografia meravigliosa, dei dialoghi profondi, delle citazioni ineguagliabili (per chi ama il periodo storico e le figure letterarie e no del tempo). In tutto questo, la Londra vittoriana è stata ricreata in modo davvero ineccepibile, dai colori, agli abiti, passando per le espressioni, questa Londra regala un’atmosfera particolare, cupa e oscura ma al contempo magica e raffinata, proprio come era al tempo nella sua divisione tra alta società e popolo. Gli interpreti ci hanno regalato delle performance magistrali, a cominciare da Eva Green che con la sua Vanessa è spesso e volentieri riuscita a trasmetterci tutta l’angoscia e le inquietudini unite alla grande forza interiore di questo personaggio.
Insomma, la fine di Penny mi ha lasciato l’amaro in bocca, mi sono abituata alla sua “fine” ma non l’avrei voluta, avrei voluto continuare a seguire le vicende di questa “bizzarra” squadra…e invece no, il 2016 me l’ha portata via.

The Good Wife
#DilloconAlicia

The Good Wife è una delle mie serie preferite, le quali si contano sulle dita di una sola mano.
Per 7 anni i lunedì hanno avuto un senso; complice l’uscita alle calende greche dei sottotitoli e il conseguente utilizzo dei sub eng, qualsiasi cosa avessi dovuto fare la mattina, cascasse il mondo, la giornata doveva partire con la puntata della brava moglie.
Robert e Michelle King, i due creatori, hanno sapientemente mescolato diversi generi, distaccandosi dal puro e semplice procedurale, introducendo una buona dose di drama e punte di comedy, volte ad alleggerire la narrazione.
Ciò che ne è venuto fuori è quella che considero la migliore serie broadcast degli ultimi 15 anni, in grado di competere con i prodotti cable e di non risentire dei lunghissimi 22 episodi a stagione.
I King non hanno avuto paura di andare dritti per la propria strada (senza mai piegarsi alle richieste degli shipper), chiudendo con un finale schietto, cinico e per nulla buonista. E d’altronde non poteva esserci altra fine per la protagonista Alicia Florrick.
In 7 anni abbiamo imparato a conoscerla, a capire che sotto quell’aspetto docile da casalinga, umiliata dal marito, si celava uno squalo.
Il suo arco narrativo è stato molto interessante soprattutto quando, arrivati alla sesta stagione, la si è distrutta tanto professionalmente quanto sul piano personale, facendole terra bruciata e con un nuovo futuro da costruire.
Le guest star sono state il fiore all’occhiello della serie, con le loro particolarità e, a volte, stranezze; a queste si aggiungono casi sempre interessanti e ispirati all’attualità capaci di tenere sempre alto il livello d’attenzione.
E poi, che vuoi dire a una serie che riesce a uscire praticamente indenne dall’uscita di scena, non programmata anzitempo, di uno dei protagonisti?
Ora tocca solo aspettare lo spin off incentrato sul mio spirito guida, Diane Lockhart, The Good Fight in partenza il 19 febbraio.
Immaginate quanto sarà distrutta Diane per la sconfitta di Hillary Clinton!
Person of Interest

Sempre io, sempre CBS!
Il 2016 è stato l’anno in cui è giunta a termine un’altra grande serie dell’emittente: Person of Interest.
Meno premiata della precedente, con qualche difetto in più, ma comunque molto sottovalutata, Person of Interest è riuscita nell’impresa di far digerire (e amare) a me, restia al genere, una serie basata sulle intelligenze artificiali.
Ho sempre pensato potesse essere di più e che sarebbe potuto essere un perfetto gioiellino se si fossero fermati a 13 episodi a stagione. Un numero di ventidue puntate ha comportato avere episodi filler di basso livello che poco c’entrano con il livello del resto.
Nonostante questo, Person of Interest è riuscita a trattare magistralmente il tema dell’intelligenza artificiale, tanto da far provare pena e apprensione per The Machine, come se fosse un essere umano realmente esistente.
Due personaggi straordinari hanno permesso alla serie di fare un ulteriore salto di qualità: Benjamin Linus Michael Emerson e Amy Acker, rispettivamente interpreti di Harold Finch e Root. I due, splendidi nelle loro interpretazioni, hanno reso il rapporto con The Machine speciale. Mi mancheranno, tantissimo.
Le ultime stagioni, con il conflitto tra le due nuove divinità, hanno permesso di sganciarsi dal mero procedurale, che per lo più aveva caratterizzato le prime stagioni, trattando tematiche più profonde e complesse.
E la stagione finale da 13 episodi – lo so, è stata una concessione per chiudere degnamente la serie – mi ha reso molto contenta e soddisfatta.
Vi lascio con i minuti finali: è d’obbligo risentire il “Can you hear me?” (chi ha visto Westworld nel primo episodio sarà saltato dalla sedia, Nolan burlone).
E grazie Ramin Djawadi per le splendide colonne sonore!
The Fall


Abbiamo dovuto aspettare due anni ma alla fine questo 2016 ci ha portato la terza stagione di The Fall – peccato che fosse l’ultima… ma ne è sicuramente valsa la pena, perché la serie ha avuto la conclusione che meritava, intensa e senza rimpianti. L’aspetto più interessante di questa terza stagione credo sia stato, ancora una volta, l’aver giocato sulle duplicità di Paul Spector: assassino calcolatore e spietato, di una freddezza clinica, ma anche padre amorevole e uomo dall’innegabile fascino, in grado di attirare chiunque nella sua orbita. Così anche da spettatrice ho vissuto nel dubbio, divisa fra la convinzione che la sua amnesia fosse un semplice escamotage per evitare il carcere ed il credere effettivamente che invece fosse una reazione inconscia per superare l’orrore di quanto aveva commesso. In questo assolutamente ineccepibile l’interpretazione di Jamie Dornan, che con quello sguardo è in grado di perforare lo schermo e di farti gelare il sangue.


















Masters of Sex

E se per The Fall ho potuto dirmi soddisfatta, la conclusione di Masters of Sex è arrivata come una coltellata al cuore. Nella recensione della quarta stagione (che vi metto qui nel caso qualcuno se la fosse persa) ho cercato di mantenere un contegno e rendere al meglio le mie impressioni su tutta la stagione, ma ora che si sta parlando di conclusioni e che posso tirare le somme dell’anno passato, posso finalmente sfogare tutto il mio dolore per questa cancellazione. Showtime ha fatto una carneficina di tutti i miei feels, regalandomi una quarta stagione splendida e annunciando poi, a poche settimane dalla messa in onda del finale, la cancellazione della serie; ed io che ho seguito Masters of Sex dall’inizio, che ho riposto la mia fiducia in quel pilot senza restarne delusa (una volta tanto) e che per quattro anni mi sono immersa nell’eleganza di un mondo fatto di tubini e perfetti tratti di eyeliner e rossetti rossi, ho capito subito che il vuoto lasciato da questo show difficilmente sarà riempito da qualcos’altro.

Il rammarico più grande è il senso di incompiutezza, dato che (a parte una Libby Masters in stato di grazia e finalmente in viaggio incontro al suo happy ending) per tutti i personaggi le storie son rimaste inconcluse, e con ancora tanto, davvero tanto da raccontare. Per Bill e Virginia si stava aprendo un nuovo mondo: dal punto di vista personale avrei finalmente voluto vedere come avrebbero gestito le cose ora che erano una coppia a tutti gli effetti, agli occhi del mondo intero e non più nascosti sotto falso nome in qualche camera d’albergo, ed anche dal punto di vista dello studio gli scenari erano veramente infiniti, con la possibilità di un confronto con altri esponenti del movimento della rivoluzione sessuale da loro iniziata e di ampliare la ricerca introducendo anche il tema dell’omosessualità. Almeno ho avuto la soddisfazione di vederli convolare a nozze alla fine di un percorso personale in salita e per questo ancora più meraviglioso. Così come rimarrà il rammarico per Betty, la mia Betty, che avrei tanto voluto vedere lottare per riprendersi quella bambina frutto dell’amore con Helen. La vita a volte è davvero ingiusta, con noi addicted soprattutto, e questo finale è stata un’ingiustizia bella e buona.
Galavant
E in un mare di show “mostri sacri” che ci hanno accompagnato per diversi anni con le storie dei loro indimenticabili protagonisti, permettetemi una mini-parentesi per parlare di una serie magari meno celebrata che è invece stata con noi per poco, davvero pochissimo tempo: solo 18 episodi totali divisi su due brevi stagioni che non facevano in tempo a iniziare e già ti abbandonavano con ancora in testa i loro orecchiabili ritornelli.
Sto ovviamente parlando di GAAAALAAAAVAAAANT (*se l’avete letto cantando siete decisamente stati contagiati anche voi*).
Galavant non sarà stata la rivoluzione seriale del nuovo millennio, ma per quanto mi riguarda è stato un confortevole angoletto colorato fatto di personaggi più o meno stravaganti e risate assicurate in cui andarmi a riparare in una giornata uggiosa o magari dopo una brutta settimana al lavoro.
Chi ha scelto di farsi conquistare dal mondo fiabesco e canterino di questo show sentirà immensamente la mancanza dell’atipico eroe (anche se fortunatamente, per la serie anche l’occhio vuole la sua parte, Joshua Sasse è rimasto ancora un po’ nel nostro mirino scruta-manzi grazie a No Tomorrow), della principessa Isabella, del fedele Sid, dell’irritabile Madalena… perfino di comprimari come lo chef Vincenzo e il Giullare, personaggi che normalmente spariscono all’interno della narrazione ma qui vengono esaltati da momenti esilaranti che li vedono protagonisti. Ma, per quanto mi riguarda, so che quello di cui più di ogni altro sentirò la mancanza sarà re Richard, protagonista di un’adorabile bromance con il fido Gareth prima e di una sottotrama romantica poi, nella seconda stagione, in cui diventa anche un insospettabile nuovo alleato per Galavant stesso. Richard a cui mesi fa ho dedicato un articolo apposta, per dichiarargli il mio eterno amore per le grasse risate e i teneri “awww” che mi ha procurato in quelle poche settimane in cui ho avuto il piacere di immergermi in questo bizzarro regno pseudo-fantasy.
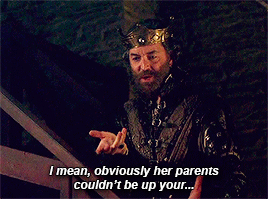
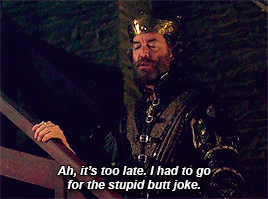
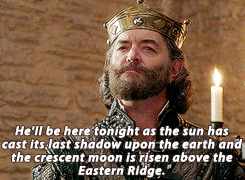

Molti si sono fatti scoraggiare dal formato comedy/musical di questo show, che però ha molto più in comune con dei film parodia che con i lungometraggi Disney tutti true love e canzoncine che sembrerebbe voler ironicamente emulare… beh, il collegamento disneyano non è a caso visto che i testi delle canzoni che accompagnano le vicende dei nostri protagonisti vengono direttamente dalla penna di Alan Menken, compositore di innumerevoli colonne sonore e pluripremiato premio Oscar per il suo apporto ad alcuni tra i miei film Disney preferiti (anche grazie alle meravigliose canzoni) come La Bella e la Bestia e Aladdin. Ma scordatevi uccellini che aiutano la principessa di turno a ripulire la casa, Galavant è l’antitesi di quello che credete di trovare in uno show in stile musical, con una colonna sonora che accompagna trovate più o meno strambe in maniera piuttosto naturale e per me mai pesante.
Il finale ha visto un happy ending sia per il nostro eroe che per il suo nuovo amico Richard, con gli autori che evidentemente sentivano in un certo senso il bisogno di chiudere almeno le trame principali in vista di una cancellazione che era già nell’aria, eppure il destino ancora incerto di Madalena, passata definitivamente al “lato oscuro”, e la missione di Gareth per salvarla avrebbero potuto essere basi più che valide per lo sviluppo di un’ipotetica terza stagione, quindi mi è dispiaciuto non poco scoprire che la ABC aveva infine deciso di calare quella scure che aveva “misericordiosamente” lasciato a pendere l’anno prima… ma mi consolo col fatto che YouTube è pieno di video che possono in qualsiasi momento rinfrescarmi la memoria su alcuni dei momenti clue della serie.
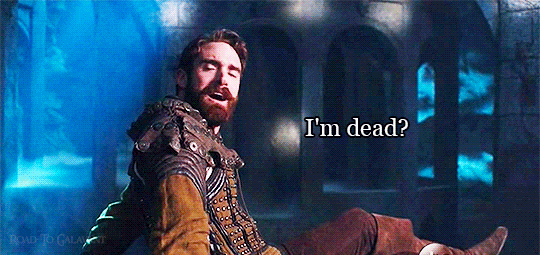

Nonostante il breve corso credo che per i suoi fan Galavant avrà sempre un piccolo posticino nel cuore… e decisamente un enorme spazio in quella parte di cervello dove in genere vanno a relegarsi i motivetti orecchiabili che ti si ripropongono poi inspiegabilmente a distanza di anni (beh, Inside Out mi ha dato un mezza spiegazione a riguardo, ma nel caso delle canzoni di Galavant in genere la mia reazione al ricordo tende a essere più un mezzo sorriso da ebete accompagnato, se non c’è nessuno nei paraggi, anche da un sing-along).
– Ale
Castle

Chi ha seguito tutta l’epopea del capitolo conclusivo di Castle, sa che non si è trattato di una pura e semplice “cancellazione”. Oh, s’è fatto tardi, andiamo tutti a casa”. Certo. Facile così. Facile salutarsi con interviste, abbracci e baldoria e sentiamoci presto, rimaniamo in contatto. Big, big NO. È stata una vera e propria débâcle.
Dare il colpo di scure definitivo è stato un atto di misericordia, per il quale abbiamo lottato ed esultato che nemmeno i bei vecchi tempi di “Il cielo è blu sopra Berlino”. E a maggio è così pietosamente calato il sipario su una pessima gestione di pubbliche relazioni da parte del network che lo mandava in onda, che a confronto le riunioni condominiali sono un’oasi di pace e fratellanza.
In tutto questo, un fandom fedelissimo, che amava i Caskett al punto da preferire incidersi il cuore con una punta di diamante, piuttosto che vederli privati del loro lieto fine, si è trovato con trenta secondi di “finale di serie” in cui è stato emotivamente aggredito da frotte di bambini (io a un certo punto ne avevo contato uno in più ed ero atterrita: quattro figli?!), Beckett sempre incinta (pensandoci a ritroso) e Caskett curiosamente ringiovaniti. Finale di cui per settimane si è dibattuto gravati dallo spinoso dilemma: “Ma è un sogno degli ultimi istanti prima di morire? Mi confermate che sono vivi? Giurami su quanto hai di più sacro che non sono morti”. E c’è voluto del bello e del buono per convincerci tutti che erano VIVI ed era VERO, erano proprio tutti figli loro. (Io ci ho creduto subito e pure se erano morti, per me sticazzi erano vivi lo stesso). Questo per spiegare in breve il grado di disorientamento da universo parallelo kafkiano, in cui siamo precipitati tutti per quattro settimane. E non sto citando per decenza le perle più significative.
Ma Castle è stato TUTTO, prima dell’inspiegata follia finale. È stato allegria, affetto, magia, ossessione, cuore leggero tre metri sopra il cielo dopo la puntata del martedì mattina all’alba, farfalle nello stomaco all’uscita degli spoiler e degli sneak peek (*giuro che questa volta voglio arrivare ignara a lunedì – diceva aprendo nervosamente il link con mani tremanti). Infinite, minuziosissime congetture su qualsiasi aspetto dello scibile umano, analisi rigorose con i più moderni ritrovati tecnologici. Sono stati gli occhi a cuore di Beckett e gli sguardi di Castle. È stata la rassegnazione di mariti, partner e amici: “Domenica non possiamo uscire perché c’è la premiere di Castle” “La premiere è lunedì” “Infatti. Metti che poi mi succede qualcosa? Preferisco rimanere qui immobile sul divano”.
Castle è stato un procedurale alleggerito dei tratti più aridi e noiosi (manco mi piacciono i procedurali), che non si è mai preso sul serio e che ci ha divertito con un umorismo che non era comicità a basso costo (almeno non fino all’ottava stagione, talvolta “tagliata con il fulciotto”, come si dice da noi). Ha creato una delle migliori storie d’amore in circolazione (il pezzo è mio, quindi, lo dico: la miglior storia d’amore che io abbia mai osato sperare di vedere nella mia vita), costruendola con pazienza, rispetto e minuscoli passi che l’hanno resa indistruttibile (alla faccia di chi “Tutto finisce, anche una storia d’amore epica come la vostra”. Sì, pure la tua fantasia creativa, comunque. Ritenta e sarai più fortunato). E la sexual tension? Qualcuno ha superato indenne le prime quattro stagioni? Io ho ancora il mal di fegato a pensare a quanto ho spasimato per vederli insieme.
Castle è stato unico nel suo genere, un prodotto perfetto e godibile, capace di farti dimenticare per quaranta minuti i generali cazzi della vita quotidiana. E la magia si rinnova, per me, a ogni rewatch. I Caskett si sono staccati da ogni bassezza, librandosi sopra gretti e meschini interessi, per rimanere eternamente uniti ed eternamente nostri (sì, volevo una chiusura retorica. Divento sempre emotional quando ne parlo). Ora non so se dovrei aggiungere qualcosa tipo l’immagine di me che saluto i Caskett che si allontanano al tramonto, piangendo e augurando ogni bene, ma non ci penso nemmeno. Vado via anche io in moto con loro. E tanti saluti.



– Syl
Marvel’s Agent Carter
Io non posso ancora accettarlo. Negli anni, il mio essere telefilm addicted ha subito il mio stesso percorso di crescita, cambiando a volte nei punti di vista, nelle opinioni, nei gusti, ma soprattutto maturando e approdando a una triste verità: all good things come to an end, e come tali, anche le serie tv migliori devono … affrontare il corvo alla fine della loro storia, alcune prima di altre. E nonostante faccia sempre terribilmente male, negli ultimi tempi avevo in qualche modo imparato a fare i conti con questa difficile realtà, dicendo addio con malinconia ma accettazione ad alcune delle mie serie tv preferite. In definitiva, a volte ancora piango abbracciata al cuscino ma vado avanti. Con Peggy Carter però è stato diverso. Peggy Carter meritava di più. Più della scarsa considerazione del suo network, più della mancata pubblicità e degli spazi ritagliati, più di ascolti che non rispecchiano l’effettiva portata del seguito che questo personaggio ha ottenuto fin dalle sue origini.

“Marvel’s Agent Carter” era per me il modello, era la realizzazione di un desiderio che tutti noi abbiamo espresso almeno una volta di fronte a quel personaggio di un film o a quella guest star di pochi episodi che si staglia prepotentemente dal panorama caratteriale e si impone nel suo spazio, spingendoci a immaginare quanto meriterebbe un mondo solo suo, un palcoscenico su cui risplendere come protagonista. Ed è esattamente ciò che Michele Fazekas & Tara Butters hanno fatto per Peggy Carter. Già dalla sua prima comparsa in “Captain America: The First Avenger”, il personaggio di Peggy si era mostrato in tutto il suo potenziale, aprendo una finestra purtroppo inevitabilmente ridimensionata sulla vita e sulle sfumature caratteriali di una donna intenzionata a stravolgere gli equilibri sociali in una società ancora troppo chiusa, dominata per la maggior parte dagli uomini, “custodi di forza ed eroismo”. Ma già nelle prime pennellate di quello che sarebbe stato un ritratto per il momento solo abbozzato, Peggy si eleva dall’ordinarietà e dalle convenzioni sociali che la volevano dietro una scrivania e impone la sua presenza sul campo di battaglia, al fianco del Colonnello Chester Phillips, forte del suo rispetto ma soprattutto sicura del suo posto, del suo valore, della missione di cui è investita, della possibilità di fare la differenza anche se il mondo intorno farà sempre del suo meglio per convincerla del contrario.

Ed è questo aspetto del personaggio che Fazekas & Butters hanno fatto proprio, hanno esplorato in tutti i suoi meravigliosi dettagli, per poi presentarsi al pubblico nel 2015 con una serie che finalmente dona a Peggy Carter l’attenzione che merita dall’inizio. “Marvel’s Agent Carter” riporta Peggy al punto di partenza dove il tempo sembra essersi riavvolto per lei, essendo nuovamente ignorata e sottovalutata dai “grandi uomini” del SSR. Una delle ricchezze maggiori della serie è stata per me la possibilità di assistere, con i miei occhi questa volta, al percorso di crescita di Peggy Carter, alla sua costante lotta per rinnegare l’omologazione sociale, per continuare a camminare controcorrente in una realtà in cui sembrano tutti terribilmente uguali, sino a costringere chiunque la circondi ad aprire gli occhi e a vederla per davvero, o forse semplicemente era lei ad aver bisogno di rivedersi ancora una volta com’era successo in passato.

Parlare di quanto importanti fossero dal punto di vista sociale un personaggio come Peggy e una serie come “Marvel’s Agent Carter” meriterebbe spazio e tempo individuali, ma fondamentalmente credo che si riduca tutto alla sua frase più iconica, “I know my value and anyone else’s opinion doesnt’t really matter”. Peggy Carter è una donna e un agente negli anni ’50, è il simbolo dell’indipendenza, dell’umanità, delle fragilità e dei pregiudizi subiti ma è anche l’emblema del coraggio di chi abbraccia ogni sconfitta e ogni perdita per poi rialzarsi, scrollarsi la polvere dalle spalle e riconoscersi più autentici di prima.


E accanto a questi significati così catartici secondo me, si affiancano componenti caratteriali e narrative dello show assolutamente pregiate e di una tale qualità da non poter passare inosservate. Personaggi come Sousa, Thompson, Wilkes, Rose si scoprono nel tempo in un percorso talmente graduale da essere assaporato in tutte quelle sfumature impercettibili a prima vista. Ma se lo chiedete a me, dopo Peggy, il regalo più grande che la serie ci ha lasciato è Edwin Jarvis. Negli anni in cui essere una voce senza corpo era solo il suo incubo peggiore (le perle di sceneggiatura a riguardo sono una vera delizia), Edwin Jarvis, reso magistralmente da James D’Arcy, è esattamente il personaggio di cui ancora non sapevamo di aver bisogno nonché l’unico a mio parere in grado di affiancare Peggy come solo Steve aveva fatto in passato.


Irresistibilmente imbranato, geneticamente elegante, romantico e passionale quando serve, leale e coraggioso come nessuno si sarebbe aspettato, Jarvis occupa il suo spazio senza neanche provarci, raggiungendo con umiltà Peggy sul suo stesso livello e restando al suo fianco come nessun altro meriterebbe. La partnership tra i due è tremendamente caratteristica, è giusta, e conquista la scena, mentre il loro rapporto umano diventa una costante di cui non si può più fare a meno.


Ma in fondo cos’è un eroe senza il suo villain? “Marvel’s Agent Carter” aveva pensato anche a questo, portando nella serie due personaggi pieni di fascino e di storia, impossibili da odiare per davvero perché innegabilmente catturati da una profondità che a volte sembra scarseggiare nei film. La “vedova nera” Dottie Underwood e la nemesi Whitey Frost hanno reso la missione di Peggy degna di essere vissuta e combattuta, diventando per lei l’unico vero ostacolo in quanto tutte e 3 lottavano sullo stesso livello e contro quelle stesse regole che non accettavano.


L’atmosfera che si respirava nella serie era autenticamente Marvel, era originale, intesa, composta con piena consapevolezza del mondo in cui si collocava e con quel tocco period che rendeva tutto ancora più interessante. Il tutto mentre Hayley Atwell brilla letteralmente di luce propria e migliora la tua esistenza in soli 40 minuti settimanali.

Quindi no, per questi motivi e per molto altro ancora, non accetterò mai la cancellazione di “Marvel’s Agent Carter” perché credo che si possa affermare con sicurezza che al momento, nel panorama televisivo seriale, non esista nessuno come Peggy Carter. E forse non esisterà neanche nel prossimo futuro.

Secondo voi invece quali sono le migliori serie TV che ci hanno salutato definitivamente nel 2016? Correte a farcelo sapere nei commenti!
Rectify 😛
Ciao addicted! Mi scuso con gli autori degli articoli riguardanti gli altri telefilm ma non gli ho degnati neanche di uno sguardo o di una lettura veloce, magari ci tornerò sopra dopo. E perché? Ma perché sono andata di corsa a cercarmi Castle! Eh sì, la mia vita telefilmica ha subíto un elettroshock alla chiusura della serie, nonostante il contentino finale! Non vorrei essere ripetitiva, infatti ho già detto tutto in altre recensioni. Condivido pienamente quanto scritto e mi consolo con le repliche (anzi rewatch!) e con la lettura delle fanfiction! Arrivederci e buon anno a tutti!